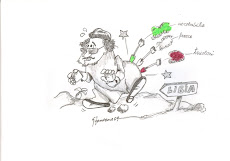giovedì 27 ottobre 2011
Un giorno d’ordinaria tristezza
“Non chiedere per chi suoni la campana. Essa suona per te”.
E la campana suona.
Si entra nell’ampio e lungo corridoio, dove misere lampade con luce di un bianco sporco vorrebbero essere imitazione del sole, che in quel luogo non ci sarà mai;
e non solo per quel giorno d’autunno, dove la pallida stella si nasconde nel grigiore e nelle nuvole, che s’apprestano alla pioggia.
Lì, sempre è notte, anche se le ampie vetrate vorrebbero invitare l’astro ad entrare.
Non può: lì nulla è più come prima.
I fili di luce si sono interrotti, sono stati strappati, così come la trama del tempo e dello spazio, dove esiste solo un immenso buco nero, che tutto cattura, tutto cancella, senza più rilasciare;
è un universo parallelo, ma con scintille, che via via si estinguono, una dopo l’altra.
Il cuore si stringe, la mente migliore vacilla, il dolore di chi arriva dall’universo di luce strazia, nel cercare un varco tra quelle tenebre.
La lunga passerella di piastrelle rilucenti riverbera quella luce innaturale e fredda, mentre i muri di un giallo pallido e le porte di un azzurro tenue vorrebbero imitare il sole e il cielo, nel dare calore e sollievo ad anime ormai stanche, secche, prosciugate.
Fuori delle stanze, allineate ordinatamente, porta dopo porta, eccole, le poverelle: aspettano, in un mondo in cui anche il tempo è rallentato, legato come grano di rosario ad un filo, che si potrebbe spezzare da un momento all’altro.
“Nessun uomo è un’isola,
completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto”.
Eppure, il maglio del destino ha frantumato il legame, lanciando e lasciando piccoli frammenti d’umanità alla deriva.
Sono i non morti.
Ma neppure più vivi.
Da un lato come dall’altro, le carrozzine con quei corpi piegati e piagati, formano una lunga fila, che si perde per tutta la lunghezza di quel condotto, rimpicciolendo sempre più, tanto quanto si sforza di arrivare lo sguardo, sino a perdersi, in fondo dove s’indovina il muro;
dove finisce lo spazio, orfano di secondi, minuti, ore, giorni, mesi ed anni.
“Se anche solo una nuvola
venisse lavata via dal mare,
l’Europa ne sarebbe diminuita,
come se le mancasse un promontorio,
come se venisse a mancare
una dimora di amici tuoi,
o la tua stessa casa”.
Con un senso di vertigine, noi, i “vivi”, cerchiamo il nostro “non morto”, come a scegliere la propria bicicletta nell’insieme di tante esposte sulla rastrelliera.
Eccoli: sono i nostri padri o madri, per altri, i nonni o le nonne;
per i più sfortunati, i compagni, le compagne o, peggio, i figli.
Non sono più in sè, oppure lo saranno per poco: quel tanto che basta al malefico buco nero che si è formato nella loro testa, per risucchiare tutti i pensieri, i ricordi e, alla fine, ogni minima coscienza di sè, dell’essere, della propria personalità, dell’Io esistente.
Ogni cosa sarà inghiottita da un tarlo famelico, che porterà a consumazione lo spirito e la carne, fino a che una nera signora passerà, pietosa, a terminare lo scempio, la corrosione e il disfacimento, rubando l’ultimo soffio, come il sagrestano, quando spegne la candela sull’altare, a messa finita.
“La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,
perché io sono parte dell’umanità”.
Ma dov’è la vita?
«Rosa...Rosa...mamma» sussurra una figlia, a quella donna stesa su quella carriola a rotelle.
Rosa, la mamma, ha gli occhi chiusi, la bocca perennemente aperta vuota d’ogni mordente;
un pertugio che pare il dove l’essere suo si è sfilato dal corpo, per lasciare un guscio vuoto.
Dov’è Rosa?
E Sebastiano, dov’è, che passa avanti e indietro, in un continuo strascicare di piedi:
le mani abbandonate sui fianchi, fisso lo sguardo, con gli occhi che non sono più specchio d’anima.
Il temporale scoppia all’improvviso e l’acqua portata dal vento sembra una mano che schiaffeggia i vetri, quasi volesse violare anche quella dimora di sofferenza.
Le luci, per un attimo, si abbassano per poi riprendere vigore, quasi orgogliose di brillare di luce propria, non più in competizione con quella palla di fuoco che, nel cielo terso, altrimenti le oscurerebbe.
Qualcuna si fulmina.
Come quegli sfortunati, ormai fantasmi, anche se rimane la carne.
Guardo le foglie trasportate dall’impeto della tempesta: anch’esse, una volta verdeggianti, nel fulgore e nella bellezza della giovinezza, ora sono in balia d’ogni avversità.
Impossibile non prevedere stessa sorte, per le mie anime morte.
Non so in che paese ora stanno e se il buon Dio ha già reclamato quei figli suoi, lasciando ancora a noi di contemplare quella carne abbandonata.
“E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te”.
E la campana ancora suona.
Le infermiere improvvisamente riappaiono, con la frenesia e la laboriosità di formiche o api operaie, che riprendono la cura di quello a loro affidato.
Ogni carrozza ritorna al suo posto, dopo che tante mani hanno accarezzato quelle guance, quelle teste ormai svuotate, quelle mani ormai abbandonate, quelle ginocchia che, quando si era piccoli, ci tenevano sopra, mentre loro ci raccontavano le fiabe del focolare.
Un’angoscia cocente ancora spreme il cuore, come pugno il limone.
Si passa vicino al salone, dove i pochi che ancora tengono un barlume di consapevolezza, guardano la televisione.
Sono ammucchiati: tante carrozzine avvicinate, tanto da sembrare ingorgo sulle strade più battute.
Come un sol uomo, tutti si girano, guardando noi che usciamo.
Loro no...mai più, da vivi.
“Viator Viator, quod tu es, ego fui. Quod nunc sum, et tu eris”...
Pellegrin che guardi a me, io ero come te, un bel dì sarai com'io, pellegrin Addio Addio.
Io, secondo me...27.10.2011



















































































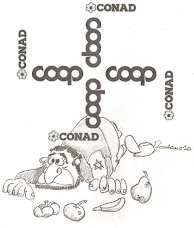













e.jpg)



















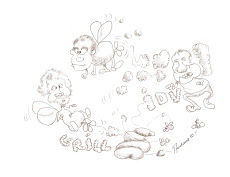
malista.jpg)